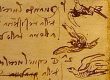Perché a Firenze i gay si chiamano “buchi”? Ve lo raccontiamo noi!
Sapevate che il primo locale gay d’Italia fu aperto proprio a Firenze nel 1974? Ormai chiuso, il Tabasco inizialmente ospitava eventi di carattere artistico, poi si trasformò in un locale per drag e cabaret musicale, fino a che, dopo gli anni Ottanta, diventò un punto di riferimento della movida gay fiorentina e toscana. Stilisti, artisti e festaioli sono passati dal Tabasco e ancora oggi molti di noi si rammaricano della sua chiusura. Ma cosa contribuì a rendere possibile questo miracolo italiano? Tanto per cominciare, la sua posizione ben celata agli occhi della popolazione. Il Tabasco, infatti, localizzato in Piazza Santa Cecilia, un enclave di Piazza della Signoria, era perfettamente invisibile: l’ingresso, nascosto da un pesante portone con tanto di feritoia per scrutare gli avventori prima dell’ammissione, conduceva a una rampa di scale che scendevano per varie decine di metri sotto il piano stradale. Per usare un’espressione fiorentina, si diceva che il locale era “imbucato”, cioè era proprio… un buco!
Il Chiasso del Buco
Tuttavia, l’etimologia del termine “buco” si colora di aspetti particolarmente interessanti dal punto di vista storico e va molto indietro nel tempo. Non lontano da via Lambertesca, infatti, proprio nel pieno centro della città, esiste un vicolo noto come Chiasso del Buco. Si tratta di un luogo silenzioso, lontano dai flussi turistici, isolato sia nello spazio che nel tempo, dove, secondo gli storici, sorgeva una taverna nota a tutti come “il Buco”, gestita da un rinomato sodomita di nome Antonio Guardi. L’oste era chiaramente piuttosto conosciuto a Firenze per i suoi comportamenti, tanto che sia le cronache giudiziarie che la letteratura popolare lo mettono al centro di una rete di sodomiti che vivevano e operavano nel cuore della città medievale.
Il Guardi figura in un popolare componimento poetico quattrocentesco scritto da Stefano Finiguerri, soprannominato “Za”, intitolato La Buca di Monteferrato (secondo l’analisi filologica del prof. Antonio Lanza, sarebbe più corretto indicare il titolo del poemetto con La Buca di Montemorello). Il poeta finge di essere visitato in sogno dal banchiere Tornaquinci, uno dei borghesi più ricchi della città, che gli rivela il segreto del Guardi: un segreto, a quanto pare, sulla bocca di tutti, perché il taverniere era “compagnio di quel de Frachassini et molta soddomia insieme fenno”. Tornaquinci, poi, racconta di una sfilata di circa duecento fiorentini, nominati uno per uno per nome e cognome, che scendono a turno in un “buco” nella montagna dove si cela un tesoro. Naturalmente, non occorre essere fini simbolisti per capire che la montagna è una rappresentazione metaforica del sedere maschile!
Insomma, il locale di Antonio Guardi doveva essere piuttosto popolare e non è sbagliato dire che dovette essere il primo locale gay della Firenze tra Medioevo e Rinascimento. Nonostante la sodomia fosse un reato, gli affari della taverna andavano piuttosto bene, poiché oltre al consumo di bevande, il Buco offriva protezione e privacy, nonché delle vere e proprie dark room per il sesso occasionale. Nel 1494, un beccaio (“macellaio” in fiorentino) di nome Damiano di Taddeo si serviva delle stanze del Buco per incontrare giovani uomini che condivideva con i suoi tre fratelli. E non era certo l’unico! Michael Rocke nel suo fondamentale studio sulla sodomia a Firenze cita centinaia di uomini finiti nei registri giudiziari per questo comportamento e molti di loro erano legati al Buco.
Il Buco e la legge
Il governo della Signoria fiorentina cerca in ogni modo di contrastare le attività della taverna con leggi che limitavano e, in certi casi, vietavano, il consumo di bevande alcoliche all’interno del locale per prevenire forme di socializzazione omosessuale. Più tardi, anche i predicatori come Bernardino da Siena si scaglieranno contro i buchi che condannano per la loro fama ignobile, invocandone, se non la demolizione, per lo meno la chiusura anticipata. Tuttavia, nonostante le interdizioni, i buchi prosperano sia in numero che in clientela e in pieno Quattrocento se ne contano addirittura 30 a Firenze, con clienti del calibro di Niccolò Machiavelli e Lorenzo il Magnifico.
Buchi dai nomi evocativi come il Fico, la Malvagia, il Porco e il Panico diventarono popolari luoghi di ritrovo per una clientela promiscua e dedita al sesso, anche nelle sue manifestazioni più commerciali, in piena linea con l’animo mercantile della Firenze quattrocentesca. La prostituzione (anche femminile, da cui il termine “bucaiola”, ancora in uso a Firenze per identificare una prostituta) era molto frequente in questi luoghi e se ne hanno prove documentate: nel 1492, tre cuochi del Buco del Chiassolino furono condannati per sfruttamento della prostituzione maschile nel loro locale, mentre Albizzo di Jacopo, il proprietario del Frascato, un lupanare in cui sodomiti e prostituti potevano lavorare in sicurezza, finì nelle cronache giudiziarie nel 1493 e nel 94 per aver tenuto un ragazzo “come moglie” e poi per averlo sodomizzato.
Tra passato e presente
Quindi, sebbene vari secoli separino il Tabasco e i buchi, non possiamo fare a meno di collegarli in una sorta di mappa della Firenze sodomitica che, sorprendentemente, può essere ancora rintracciata nella topografia urbana. Evidentemente, a Firenze, dove passato e presente si legano in maniera inestricabile, certi luoghi sono diventati parte del genius loci entrando a pieno titolo anche nel lessico comune!